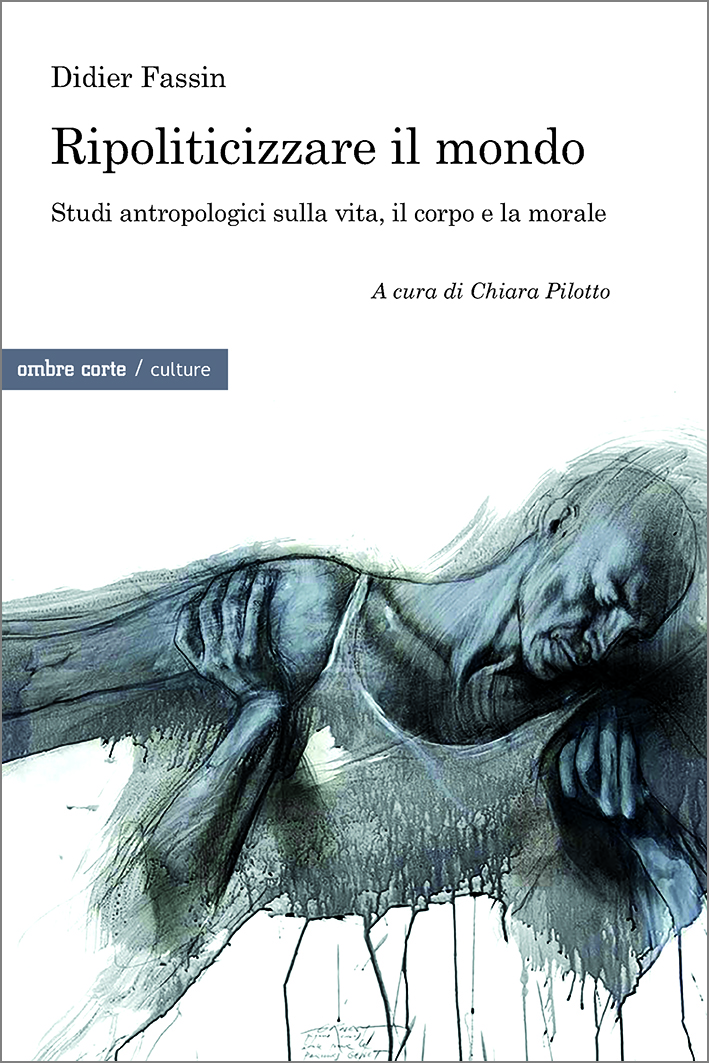RASSEGNA STAMPA
DINAMOPRESS – 23 luglio 2023
L’intollerabile attuale o dell’attuale intollerabile
di Emilio Maggio e Massimo Filippi
In Occidente la concezione dell’intollerabile – termine che, riecheggiando l’inconcepibile e l’inammissibile, ha finito per indicare in direzione del genocidio – ha contribuito a istituire la categoria recente di umanità e i suoi corollari umanitari. La governamentalità moderna e contemporanea, infatti, si è fin da subito, seppur progressivamente, autodeterminata come un’economia politica fondata sui diritti dell’uomo e sui crimini contro l’umanità. Questo dispositivo morale si è dapprima scontrato con l’alterità di mondi ritenuti selvaggi e primitivi e, proprio per questo, da umanizzare, secondo la logica e le prassi coloniali. In un secondo momento, tuttavia, soprattutto dopo l’orrore nazista, il concetto di umanità, da proprietà esclusiva della civiltà – della civiltà che si fa Storia – è diventato sinonimo di inclusività, fino a costituirsi come simbolo morale atto a garantire a tutti gli umani le prerogative delle cosiddette politiche della vita.
Se il climax dell’espansionismo capitalista occidentale è stato caratterizzato dalla confisca di beni e corpi di altr* lontan*, si può affermare che successivamente tale requisizione si è rivolta anche contro l’umanità che aveva inventato l’umanità stessa. È infatti nel momento in cui la civiltà occidentale assurge al suo più alto grado di sviluppo tecno-politico e in cui la propaganda della sua presunta superiorità morale si fa egemone che si materializza, dentro il suo spazio politico e giuridico, il campo di concentramento: uno tra i più intollerabili tra gli intollerabili della storia dell’umanità. Attualmente, sebbene le retoriche dei diritti umani continuino a mascherare l’etnocentrismo democratico e l’esportazione a basso costo del modello di vita occidentale, si potrebbe affermare che l’intollerabile si sia frastagliato in una pluralità di intollerabili che colpiscono l’inviolabilità dei corpi sfruttati e sottomessi attraverso due tipologie di regime bionecropolitico: la sanzione e la guerra. Gli Stati occidentali, per esempio, regolano i flussi migratori dentro i propri confini attraverso l’amministrazione dell’accoglienza di individui considerat* come mere risorse da mettere a profitto, mentre fuori da quegli stessi confini continuano a esercitare il proprio dominio sui mondi altri e lontani attraverso guerre, dirette o per procura, che non fanno che alimentare all’infinito l’antico e mai superato processo di civilizzazione.
Ripoliticizzare il mondo. Studi antropologici sulla vita, il corpo e la morale, raccolta di saggi di Didier Fassin, che Chiara Pilotto ha messo in ordine con mano sapiente e che ombre corte ha avuto l’accortezza di ripubblicare, intende indirizzare l’attenzione esattamente sull’ingombrante ed invisibilizzata contraddizione che si cela dietro il paravento democratico della ragione umanitaria. Le politiche della vita – già prese in esame, tra gli altri, da Foucault e Agamben, criticati dall’antropologo francese per la loro indisponibilità a interessarsi dei problemi reali delle vite infami – costituiscono per Fassin il nodo che gli consente di riformulare la questione del biopotere in termini di biolegittimità. Se, infatti, la prospettiva foucaultiana intendeva fare luce sulla forma moderna di governamentalità occidentale come organizzazione, amministrazione e controllo della popolazione, Fassin analizza il biopotere, interrogandone i dispositivi vivi – tutto ciò che fa la vita, ciò che la regola, la contiene, la mantiene, la sostiene e, in molti casi, l’abbandona o la mette a morte – indispensabili a legittimare una vita degna di essere vissuta: a chi va garantito il diritto alla casa, al lavoro e alla salute, per fare solo qualche esempio? «Quello che la politica fa alla vita – e alle vite – non è solo una questione di discorsi e tecnologie, di strategie e tattiche. Riguarda anche il modo concreto in cui individui e gruppi sono trattati, sulla base di quali dottrine e in nome di quali principi morali, e quale tipo di disuguaglianze e di mancanza di riconoscimento venga così prodotto» (p. 39). L’antropologia di Fassin, insomma, ha più a che fare con la politica che con la cultura e, leggendo il biopotere come potere della vita, chiarisce che è la vita stessa a essere politica. Di conseguenza, poiché le vite non sono tutte uguali, compito della politica è ripoliticizzarle, fare in modo che gli individui, intesi non solo come popolazioni astratte ma come corpi in carne e ossa, possano decidere il tipo di vita che vogliono o non vogliono vivere.
Nel saggio Oltre la biopolitica, Fassin instaura un dialogo con Foucault, proponendo quattro punti che ne problematizzano il lavoro: 1. La politica non è solo l’arte di governare, ma un’amministrazione che performa le vite di tutti e di ciascuno; 2. In questo senso, le società contemporanee sono caratterizzate da un potere volto a legittimare, cioè a stabilire chi, come e quando abbia il diritto di vivere una vita degna di essere vissuta; conseguentemente, 3. La biopolitica ha senso solo in rapporto alle disuguaglianze; e, per finire, 4. Bisognerebbe capire come senso e valore, due concetti chiave della filosofia nietzschiana, che già Deleuze aveva riportato alla luce, costituiscano i parametri attraverso cui la governamentalità liberista classifica i propri cittadini in base a caratteristiche economiche, geografiche, religiose e politiche, ecc.. Il far vivere è, quindi e immediatamente, anche il respingere nella morte.
Per dare corpo al concetto di biolegittimità, Fassin si serve di molteplici esempi tratti dal suo lavoro sul campo condotto in tre diversi continenti e nell’arco di molti anni. L’analisi dell’epidemia di Aids in Sudafrica nel periodo 2000-2005, per esempio, ci restituisce le profonde disuguaglianze che caratterizzano gli accessi alle cure e ai farmaci antiretrovirali che il regime dell’apartheid aveva prodotto e sostenuto. L’antropologo francese può così affermare che la questione della biolegittimità acquista senso e valore politici in quanto entra a contatto con le diseguaglianze reali che decidono tra vita, sopravvivenza e morte. Per Fassin, riprendendo le considerazioni espresse da Derrida nella sua ultima intervista concessa a Le Monde nell’agosto del 2004, poco prima di morire, la sopravvivenza dovrebbe perdere l’accezione mitopoietica attribuitale dal capitalismo liberista, che destoricizza l’oppressione mantenendola dentro la cornice della vittimizzazione, e acquisire il valore e il senso di una vita oltre la morte. Continuare a vivere, per Derrida, significa ripristinare il ruolo politico dell’immagin/azione. Il caso di Mesias, incontrato da Fassin a Soweto, è a tal riguardo emblematico. “Grazie” alla malattia, Mesias ottiene un riconoscimento economico e quindi «una “vita normale”», nelle due accezioni di «ordinaria» e «morale»: una casa in affitto, cibo e relazioni stabili. «La malattia diventò una risorsa sociale, non solo per i suoi vantaggi economici ma anche per le sue implicazioni morali e civili» (p. 57)
Nel saggio Intollerabili antropologici, Fassin fa leva sul racconto di Kafka Nella colonia penale per evidenziare che la violenza fondativa dello Stato è inesorabilmente inscritta nei corpi de* cittadin*. La lettura antropologica del racconto offerta da Pierre Clastres in La società contro lo Stato, che “vede” il corpo come una pagina bianca su cui incidere le tavole della legge, è indice della nascita di un nuovo intollerabile e, insieme, della fine di un mondo. Ma questa lettura, ci ricorda Fassin, è ancora viziata dai preconcetti etnocentrici che condizionano i ricercatori occidentali. Se Kafka può ancora interpellarci non è perché critica la società del suo tempo, ma perché le sue storie prefigurano le nostre storie. L’imbarazzo antropologico occidentale nei confronti di usi, costumi e comportamenti considerati “barbari”, quali il kañaalen, rito praticato dai Diola della Casamance in Senegal, è il sintomo di un’interrotta presunzione di superiorità morale.
Il kañaalen è un rituale la cui interpretazione occidentale dimostra sia l’ambiguità ideologica con cui la tradizione umanitaria affronta i rituali di afflizione dei mondi lontani sia l’etnocentrismo con cui siamo soliti approcciare questioni incandescenti come quelle relative ai limiti del tollerabile che le società altre si assegnano. Come scrive Fassin, la questione dell’intollerabile andrebbe affrontata dal punto di vista antropologico e, si badi bene, questo non per sostenere una qualche forma di relativismo culturale/morale quanto per far propria una più feconda lettura “emica”, «ovvero una lettura che tenga conto delle categorie indigene» (p.115). Il kañaalen prevede la messa in atto di pratiche di “inversione” nel momento in cui la sopravvivenza del mondo diola è in pericolo. Quando «molti dei suoi figli muoiono successivamente in tenera età; quando ripetute gravidanze sono interrotte da aborti spontanei; quando un lungo periodo in cui non rimane incinta fa temere una sterilità» (p. 117), la donna diola viene esiliata dalla comunità di appartenenza e allontanata dal proprio nucleo famigliare per essere adottata da una nuova famiglia. In questo spazio-tempo sospeso, le donne colpite dal bando, dopo essere state sottoposte a diverse forme di maltrattamenti, iniziano una nuova vita da «travestite» (p. 117), vita che «realizza una triplice trasgressione delle frontiere che separano gli uomini e le donne, l’umanità e l’animalità, la vita e la morte» (p. 116). «Le tre frontiere naturali più importanti […] vengono così simbolicamente superate. Ciò rimanda alla cruciale posta in gioco costituita dalla conservazione del gruppo – o, meglio, dalla rappresentazione di ciò che la potrebbe minacciare» (p. 122). Non siamo poi così lontani dal lavoro ricostituente che Ernesto De Martino assegna a quelle istituzioni culturali nostrane, dal magismo ai pianti funebri, passando per le coreografie de* tarantolat*, in grado di fronteggiare con successo, entro determinate cornici storico-geografico-culturali, le fini dei mondi.
Fa allora bene Fassin a recuperare un po’ di storia recente per mostrarci invece l’incapacità ricostitutiva dell’umanitarismo, in cui si trovano implicate asimmetrie spaventose, inique e letali. Pensiamo, per esempio, alle cosiddette guerre umanitarie promosse dall’interventismo militare di matrice NATO: intollerabile qui significa, calcoli alla mano, che un caduto occidentale conta più di centinaia di vittime civili “loro”. Queste operazioni, al pari di altre, enunciano insomma «principi di distinzione e di gerarchizzazione tra categorie di umanità, sulla base del calcolo del prezzo delle vite di ciascuna di esse», in cui non viene tanto messa in discussione la loro umanità, quanto piuttosto si sottolinea che «il metro di misura del valore dell’esistenza umana sia un’economia delle grandezze dell’intollerabile» – «il principio di non equivalenza delle vite si esprime perciò con brutalità nell’enumerazione dei morti di guerra: estrema precisione contabile, da un lato; considerevoli fluttuazioni statistiche dall’altro» (p. 140). In altre parole, oggi non è più in questione il diritto umanitario universale – nessun* è considerat*, almeno teoricamente, inumano – ma l’eterogenea applicabilità di tale diritto che distingue tra chi «bisogna “far vivere” e chi conviene “far morire”». «Questa legge presuppone due principi: un principio di differenza, che istituisce la separazione tra coloro la cui vita è sacra , e coloro le cui vite possono essere sacrificate; e un principio di indifferenza, che subordina la protezione dei secondi all’assenza di ogni rischio per i primi» (p.141). Il nuovo ordine mondiale, sottolinea Fassin, prevede pertanto che se “noi” siamo umani come “loro”, le “nostre” vite comunque contano/valgono molto più delle “loro”.
Ripoliticizzare il mondo acquista ulteriore senso e valore se letto alla luce di quanto sta succedendo sul fronte delle normative sempre più repressive in materia di immigrazione e diritto di asilo. Le politiche della vita adottate dai paesi occidentali – e il “caso Italia” con l’attuale esecutivo reazionario ne è una delle rappresentazioni più evidenti – si sono concentrate, oltre che sui classici respingimenti, sui dispositivi atti a «trattenere il più a lungo possibile [gli] stranieri nella zona dello spazio morale in cui la loro vita è sacrificabile (in Paesi dove precisamente i diritti umani non vengono rispettati) e di evitare che raggiungano l’altra zona, dove la loro vita diventerebbe sacra (diritto umano fondamentale che a quel punto non si potrebbe più contestare)» (pp.142-43). Il caso della Libia – con cui l’Italia continua a fare affari scambiando corpi da controllare o sfruttare con tecnologie per dissuadere chi pensa di poter fuggire da guerre, fame e discriminazioni –, ormai diventata un enorme campo di concentramento a cielo aperto, e quello della Turchia – con cui l’Unione Europea stipula accordi per bloccare i flussi migratori provenienti da Est – sono qui a dimostrarlo con oscena chiarezza.
Nel momento in cui, come scrive Marcuse, «le categorie della libertà sono divenute intercambiabili con i loro opposti», la narrazione egemone trasforma la falsa coscienza in verità incontestabile. Indicativo, a tal proposito, è il fatto che i provvedimenti dei governi occidentali in materia di diritto di asilo e di protezione speciale siano sempre più svuotati da quelle garanzie in grado di permettere la conduzione di esistenze vivibili. In questa atmosfera irrespirabile, l* richiedenti asilo, per ottenere la documentazione necessaria alla loro inclusione sociale, devono raccontare e mostrare il loro corpo sofferente alle autorità competenti, sollecitandone, visto che non vi sono altre vie per sopravvivere, la generosità amministrativa. In tal modo, ci ricorda Fassin, la malattia prende il sopravvento sullo stato sociale e la confessione del disagio fisico e psicologico, ben oltre Foucault, è diventata fonte di verità. Il riconoscimento anagrafico de* stranier* passa dalla certificazione del suo calvario biografico. «La nuova economia morale deriva in realtà da una duplice costruzione: dell’umanità come specie, unica e singolare all’interno della natura, e che riunisce l’insieme degli esseri umani, per quanto diversi essi siano; dell’umanità come sentimento, definita da diritti naturali accompagnati da doveri reciproci, ma forse, in modo più fondamentale da un destino condiviso» (p.144). È per questo che la libertà di tutti gli esseri umani è sempre una libertà plurale: è la libertà di ciascun* di scegliere i modi in cui intende abitare il mondo di tutt*.
“il manifesto” – 21 novembre 2014
La politica sulla vita non fa ostaggi
TEMPI PRESENTI. Finalmente Tradotto «Ripoliticizzare il mondo» dell’antropologo Didier Fassin. Un importante saggio per mettere a fuoco le politiche sociali dominanti. E per cogliere il nesso tra precarietà e svuotamento della democrazia
di Giso Amendola
La relazione tra vita e politica ha costituito, almeno dalla fine degli anni Ottanta in poi, il tema centrale del dibattito teorico-politico, e in particolare di quello italiano. Non a caso, la biopolitica è stata individuata come una sorta di marchio di fabbrica della cosiddetta Italian Theory, Proprio in Italia, però, si è spesso corso il rischio che la genericità di un termine come vita finisse per affogare in una pericolosa indistinzione l’intera questione della biopolitica. Si può dire, anzi, che la «vita» sia spesso servita, nel nostro dibattito teorico, per neutralizzare differenze e scelte politicamente impegnative: un bel richiamo a un genericissimo vivente, specie in una cultura come quella italiana nella quale vitalismi e idealismi si sono intrecciati con malfamati esiti politici, può in fondo sempre servire a scacciare dalla riflessione politica soggetti e conflitti reali, e a rimettere in circolo con il vestito nuovo metafisiche tradizionalissime. Ciò non toglie, però, che attraverso la biopolitica sono state nominate questioni serissime, e mal si reagirebbe agli abusi e alle genericità archiviando sia il termine che la questione.
Molto utile, allora, disporre di questo Ripoliticizzare il mondo. Studi antropologici sulla vita, il corpo e la morale (ombre corte, pp. 177, euro 18, cura e traduzione di Chiara Pilotto) dell’antropologo francese Didier Fassin, già ben noto in Italia per le sue ricerche su sicurezza e polizia (di recente è stata tradotta, da La Linea, La forza dell’ordine. Antropologia della polizia nelle periferie urbane). Il libro è appunto un intenso corpo a corpo con il problema della biopolitica, intesa, con Foucault, come nesso tra politica, corpo e verità. Oltre la crisi degli alfabeti tradizionali della politica moderna, sostiene Fassin, una ripoliticizzazione, la ricostruzione di un senso complessivo dell’azione politica, è ancora possibile, ma deve calarsi nel vivo delle soggettività, dei corpi e degli affetti.
Tecniche di governo
La biopolitica resta quindi un passaggio obbligato e cruciale. Per Fassin, però, il discorso foucaultiano è insufficiente: Foucault enuncia come determinante il tema della politica della vita, ma, in fondo, lo lascia cadere quasi subito. In Foucault, scrive Fassin, dopo i riferimenti a una biopolitica in senso stretto contenuti alla fine del corso del 1977, Bisogna difendere la società, o in La volontà di sapere, l’attenzione finisce per concentrarsi piuttosto sulle tecniche di governo delle condotte (il tema della governamentalità) che sul senso e sul valore delle concrete poste in gioco oggetto di quelle tecniche. I riferimenti al potere della vita in quanto tale sparirebbero, e il Foucault governamentale produrrebbe infine una «biopolitica senza vita»: più precisamente, una politica sulla vita piuttosto che una politica della vita.
Probabilmente, queste obiezioni risentono di un certo clima interpretativo, simile a quello che ricordavamo con riferimento al dibattito italiano: letture che riducono il tema della governamentalità ad una sorta di analitica delle tecnologie di governo, in verità, non mancano. L’impressione è che, quando Fassin in sostanza obietta che l’analisi del potere marcerebbe astrattamente separata da quella del nesso soggetto/verità, colpisca effettivamente un punto critico di molte interpretazioni, ma lasci fuori invece letture più intrecciate e stimolanti del percorso foucaultiano, quelle appunto che hanno rifiutato di separare soggettività e governamentalità, soggettivazione e potere, etica e politica. Del resto lo stesso Fassin ricorda come eccedano ogni presunta «biopolitica senza vita» sia l’impegno personale di Foucault nelle lotte dei movimenti sociali, sia «il suo orientamento teorico più tardo, rivolto alla dimensione etica del governo di sé e degli altri»: il che conferma l’idea che la scelta come obiettivo critico di un Foucault che ridurrebbe la biopolitica a tecnica di governo sia debitrice a una lettura un po’ troppo compartimentata del percorso foucaultiano.
La scomparsa dei soggetti
Ma lasciamo pure agli studiosi foucaultiani queste, comunque rilevanti, questioni interpretative, e veniamo a cosa Fassin intenda poi, dal canto suo, per politica della vita. Qui lo sguardo antropologico offre molti materiali per un approccio alla biopolitica che superi decisamente ogni ambigua genericità dei riferimenti alla vita e al vivente. Non per nulla, Fassin critica con decisione un altro dispositivo attraverso il quale i discorsi sulla vita rischiano di vedersi neutralizzata la loro precisa portata politica: quello che separa di netto vita biologica e vita storicamente qualificata, il fatto di sopravvivere, la vita in sé e la «vita che si vive attraverso un corpo e come società». È alle modalità di implicazione reciproca e complessa delle diverse dimensioni che invece bisognerebbe guardare: in altri termini, ogni vita è sempre una forma di vita storicamente prodotta, contro ogni taglio tra forma di vita ed elemento biologico, quale può emergere per esempio nell’approccio di Hannah Arendt, almeno quando separa di netto lo spazio politico da quello della vita naturale (e riduce a quest’ultima dimensione tutto lo spazio dell’economico-sociale) o in quello di Agamben, in cui l’insistenza sulla nuda vita rischia di produrre «indifferenziazione del politico» e, soprattutto, «la scomparsa dei soggetti».
Niente nuda vita e niente vita in sé, quindi, non bìos contro zoè, ma vite storicamente qualificate e corpi sui quali poteri storicamente e politicamente precisabili incidono la propria azione.
Politica della vita significa, per Fassin, che il fatto di vivere, nel senso di conservare la vita, di sopravvivere, si impone come criterio di legittimità ultima dell’azione politica. Se i dominati, durante il capitalismo industriale, usavano il proprio corpo essenzialmente come fonte di forza lavoro, ora il corpo, la sua stessa esistenza in vita, si trova ad essere giocato direttamente come fonte di diritti. L’economia politica classica dello sfruttamento del lavoro si intreccia così profondamente con un’economia morale, in cui si viene chiamati ad esporre il proprio corpo, a raccontarlo, a certificarne continuamente il disagio e le sofferenze come titolo legittimo per reclamare diritti o almeno assistenza. Le indagini sul campo presentate da Fassin illustrano con straordinaria concretezza l’affermarsi di questa nuova biolegittimità e delle nuove disuguaglianze, delle nuove gerarchie che attraverso questa nuova «cittadinanza biologica» si producono.
michel-foucault
La biolegittimità è, per esempio, l’anima profonda della ragione umanitaria (tema cui Fassin ha dedicato uno dei suoi libri più noti) che si è imposta nelle politiche migratorie. Quanto più il senso politico del diritto d’asilo viene neutralizzato dalle politiche securitarie, tanto più avanza la logica umanitaria: non a caso, il sistema dei permessi di soggiorno temporanei per l’accesso a cure mediche indispensabili viene a sostituire progressivamente la possibilità, sempre più ardua, di ottenere asilo politico. La procedura amministrativa costringe ad un’esposizione sempre più individualizzata della propria storia: investe la soggettività, richiedendo il supplemento d’anima di una narrazione il più possibile patetica e persuasiva; allo stesso tempo, obbliga all’oggettività del documento, all’esibizione continua di certificati.
Sul versante della precarietà economica ed esistenziale, le cose non vanno diversamente: la piega compassionevole e caritatevole assunta da sistemi di welfare sempre più condizionati costringe a raccontare e a documentare la propria difficoltà estrema, per riuscire a sfruttare le residue elargizioni di un’amministrazione sempre più discrezionale, che mescola continuamente giustizia e pietà nelle proprie griglie di valutazione.
Nel gioco continuo di «costruzione di sé e di sottomissione allo Stato», nel «doppio processo di soggettivazione e assoggettamento», la vita diventa così il terreno sul quale si gioca la legittimità morale e politica della propria presenza. Una giovane donna haitiana può raccontare l’uccisione del padre militante politico, il rapimento della madre, lo stupro collettivo che ha subito: ma tutto questo non le varrà, nella strozzatura generale del diritto d’asilo, quanto la decisiva certificazione della propria sieropositività. I corpi sono così afferrati in un gioco di violenza politica esplicita, in cui lo Stato costringe ad esibirsi continuamente come vittima, e di violenza strutturale implicita, attraverso «l’incorporazione di un passato e di un presente violenti».
Una tragica lettura
La politica della vita, letta in questo senso, segna evidentemente un ulteriore avanzamento della forza dei processi di precarizzazione, insieme morale e politica, delle esistenze, sottomesse continuamente all’obbligo di esporre la propria estrema fragilità per mostrare la propria legittimità. E finché l’analisi si incentra sui giochi di potere incentrati sul corpo, una visione ultradisciplinare della biopolitica non può che prevalere. Del resto, lo stesso Fassin non lo nasconde: la sua lettura della biopolitica resta una lettura segnata dal tragico. Ma i testi di Fassin offrono chiavi di lettura che vanno oltre un’analisi dell’intensificazione biopolitica delle forme dell’assoggettamento.
Per comprendere la politica della vita e le contraddizioni di fondo della ragione umanitaria e compassionevole, è fondamentale l’uso, ricorda Fassin, del concetto di economia morale: quel tessuto di norme ed obblighi, di valori e di affetti, che definisce ciò che si può tollerare e ciò che intollerabile, ciò che si può fare e ciò che non si può fare, e che è indispensabile per cogliere lo spessore etico, irriducibile alle spiegazioni meccanicistiche ed economicistiche, della storia di classe. L’attenzione alle economie morali nasce appunto dentro la storia sociale delle rivolte contadine prima e operaie poi: Edward Palmer Thompson, lo storico sociale che esplicitò questa idea, la utilizzava proprio per valorizzare, all’interno della formazione della classe operaia inglese, un mondo di passioni e di usi, di simboli e linguaggi, che nessuna lettura deterministica sarebbe stata in grado di cogliere.
Esistenze coatte
In questo senso, l’attenzione alle economie morali può rompere la maledetta circolarità del «doppio processo» di assoggettamento e di soggettivazione, e permetterci di scoprire, anche nelle zone dei subalterni e dei marginali, le mille strategie della produzione di soggettività. E proprio in queste strategie, precarie ma costanti, spesso di sottrazione e di sussistenza, ma anche di rifiuto e di rivolta, le politiche della vita incontrano continuamente la possibilità di una rottura.
Così, anche la ragione umanitaria si mostra continuamente attraversata da storie collettive che la modificano continuamente; resistenze che possono forzarla dall’interno e trasformarla radicalmente, ricalandola nel fuoco dei conflitti poltici, proprio facendo leva su quel sentimento dell’intollerabile che lo stesso umanitarismo mobilita continuamente. Proprio perché la vita non è mai nuda, ma sempre storicamente qualificata, i campi dell’umanitario, del welfare caritatevole, della produzione di marginalità, sono più che mai campi decisivi di intervento politico: l’affermarsi sempre più intenso delle politiche della vita, in fondo, significa anche una sempre possibile intensificazione, direttamente politica, delle microstrategie di sussistenza e di resistenza che attraversano continuamente i luoghi dell’assistenza e del servizio sociale.
L’umanitarismo può gestire le vite, gerarchizzarle e precarizzarle nei modi più penetranti, ma lo studio delle «economie morali» ci ha sempre messo davanti momenti decisivi in cui il sentimento etico dell’intollerabile si fa motore di resistenza politica, di soggettivazione, e le strategie di sopravvivenza e di sottrazione agli obblighi e ai condizionamenti si rivelano, al fondo, forme della lotta di classe e della possibilità di «ripoliticizzare il mondo».