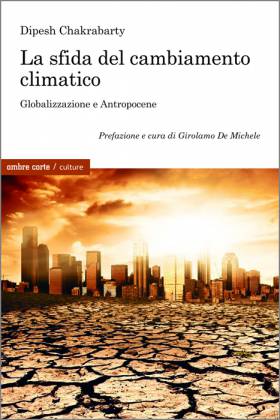Descrizione
Razmig Keucheyan
La natura è un campo di battaglia
Saggio di ecologia politica
Traduzione di Giulio Di Domenicantonio e Gianfranco Morosato
Di fronte all’annunciato disastro ecologico, è largamente diffusa l’idea che l’umanità debba “superare le sue divisioni” e lavorare insieme per affrontare le grandi sfide del nostro tempo. Ma come mostra questo lavoro di Razmig Keucheyan, la realtà è molto diversa: lungi dal cancellare gli antagonismi esistenti, la crisi ecologica tende a renderli ancora più incandescenti. Si prenda il caso della localizzazione delle discariche di rifiuti tossici negli Stati Uniti: se volete sapere dove è più probabile che vengano scaricati, chiedetevi dove vivono i neri, gli ispanici, i nativi americani e altre minoranze razziali, e dove sono i quartieri più poveri. Questo tipo di “razzismo ambientale” non è affatto limitato agli Stati Uniti: è un fenomeno globale.
Keucheyan mostra come la risposta capitalista alla crisi sia stata contrassegnata da una massiccia espansione della “finanza ambientale”. Dai “mercati del carbonio” ai “permessi di inquinamento”, dai “derivati climatici” alle “obbligazioni catastrofiche”, assistiamo a una proliferazione di prodotti finanziari legati alla natura. Invece di affrontare il problema alla radice, la strategia neoliberista cerca di trarre profitto dai rischi ambientali.
Inoltre, con l’aumento dei disastri naturali, la scarsità delle risorse, le crisi alimentari, la destabilizzazione dei poli e degli oceani e la prospettiva di decine di milioni di “rifugiati climatici”, le potenze occidentali stanno adottando sempre più una risposta militare ai problemi ecologici. Finita la guerra fredda, benvenuti alle “guerre verdi”. Da New Orleans al ghiacciaio Siachen passando per la banchisa artica, l’autore esplora i luoghi salienti di questa nuova “geostrategia climatica”.
Questo innovativo saggio di teoria politica non offre solo una realistica descrizione degli scenari capitalistici di fronte al disastro ambientale, ma anche una nuova prospettiva su alcune delle questioni più critiche di fronte alle quali oggi si trovano le nostre società.
Razmig Keucheyan è professore di sociologia all’Università di Bordeaux. È autore di Constructivsme. Des origines à nos jours (Hermann, 2007) e di Hémisphère gauche. Cartographie des nouvelles pensées critiques (La Découverte, 2017, 3a ed.). Ha curato un’antologia dei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci, con il titolo Guerre de mouvement et guerre de position (La fabrique, 2012).
Rassegna stampa
Scienza&Filosofia – S&Fn. 21, 2019
di Viola Carofalo
Nell’ultimo anno sono state prodotte e distribuite molte pellicole che raccontano la cosiddetta era dell’uomo, l’Antropocene. Due in particolare, le pluripremiate Anthropocene: The Human Epoch (2018) e L’Homme a mangé la Terre (2019) – rispettivamente di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier e Edward Burtynsky e del regista francese Jean-Robert Viallet – si concentrano sul tema della responsabilità e, in particolare, della responsabilità politica. Ricostruendo la storia degli ultimi decenni i film mostrano come la crisi ambientale sia strettamente collegata non solo a strategie di carattere produttivo, alla sempre maggiore e sregolata produzione di beni, alla velocizzazione dei trasporti, al consumo di suolo e di risorse primarie, ma anche alla guerra, nelle forme della guerra economica, della competizione tra Paesi o blocchi di Paesi contrapposti – in particolare Viallet mostra il nesso tra accelerazione tecnologica e inasprimento dei rapporti tra Urss e Usa nel corso della Guerra Fredda – e, infine, dello scontro bellico propriamente detto.
Nel suo ultimo lavoro Razmig Keucheyan (di cui ospitiamo un’intervista in questo numero di Scienza&Filosofia), docente di Sociologia presso l’Università di Bordeaux, inserisce la sua riflessione sulla crisi ecologica in questo solco. Ragionando sull’Antropocene in un’ottica che, come notiamo fin dal titolo, rimarca la sua natura politica e militare, Keucheyan esamina le ricadute etiche delle trasformazioni tecnologiche e dell’intervento sempre più massiccio e predatorio dell’uomo sulla natura. Anche Keucheyan sottolinea, come Viallet e Baichwal, de Pencier e Burtynsky, la necessità di rimettere al centro la questione della responsabilità, ma lo fa rifiutando l’idea che sia l’umanità nel suo complesso a dover essere messa sotto accusa. La tesi portata avanti in questo libro è che ci sia una netta separazione tra responsabili e vittime della crisi ecologica, separazione che ricalca quella che Du Bois ha definito linea del colore (ma che, in senso ampio, possiamo leggere anche come linea del genere e della classe).
Il testo di Keucheyan tiene assieme due piani di discorso. Il primo ricostruisce le tappe della messa a profitto del “capitale naturale”, le dinamiche di potere, i costi umani – in termini di salute e qualità della vita, nel loro senso più ampio. L’altro riguarda la narrazione, la rappresentazione, nel dibattito culturale e nei circuiti mediatici mainstream, del disastro ecologico. In particolare, riguardo a questa seconda traccia, l’autore tiene a sottolineare l’inefficacia, se non la pericolosità, di una retorica che descrive la crisi ambientale come tragedia che colpisce e coinvolge l’intero genere umano e che sarebbe dunque «capace di far emergere le condizioni di un’azione comune dell’umanità» (p. 11). Dipesh Chakrabarty ha sostenuto che, a differenza di quanto accade nelle crisi economiche, di fronte al disastro ecologico non ci sono scialuppe di salvataggio per i privilegiati. A questa lettura e all’ipotesi di una possibile azione comune, Keucheyan contrappone la necessità della radicalizzazione degli antagonismi sociali. La logica dell’intersezionalità, che ha orientato parte del dibattito politico, culturale e sociale degli ultimi anni, deve aprirsi a una nuova (quarta) dimensione, quella della natura.
La costruzione di un movimento per la giustizia climatica passa così anzitutto per la messa in luce del debito ecologico che i Paesi del Nord del mondo hanno contratto con quelli del Sud, che i ricchi hanno contratto con i poveri, gli uomini con le donne. Per Keucheyan evento rivelatore per eccellenza di questo debito ecologico e del razzismo ambientale è l’uragano Katrina che nel 2005 ha sconvolto l’area di New Orleans. Può un fenomeno naturale essere “razzista”? Sì, sostiene ironicamente il sociologo francese, se, come mostra questo episodio tragico, i più colpiti, quelli che sono stati soccorsi meno accuratamente e con più ritardo sono stati gli afroamericani e, in particolare, gli afroamericani delle classi popolari.
«Le disuguaglianze ecologiche, di cui il razzismo ambientale è una forma, rimandano a un’idea semplice: il capitalismo presuppone e crea allo stesso tempo delle disuguaglianze nel rapporto che gli individui e i gruppi di individui hanno con l’ambiente» (p. 37), come per Moore, anche per Keucheyan il rapporto con l’ambiente è – in tutte le declinazioni che questa espressione può avere – un rapporto di capitale. Resta da comprendere perché questa implicazione sia così poco indagata nell’ambito del dibattito politico e culturale e perché la questione ecologica venga frequentemente affrontata come a sé stante. Se la natura appare “esterna” ai rapporti di capitale e ai rapporti sociali, sottolinea Keucheyan, è perché il suo spazio viene prodotto – nel senso di Lefebvre – come separato, autonomo. Le associazioni ambientaliste tradizionali hanno riconosciuto con fatica, nei decenni passati, il nesso tra dimensione economico/sociale e ecologica, il movimento operaio, dal canto suo, ha avuto fin dalle origini un rapporto ambiguo con le tematiche legate all’ambiente, individuando spesso un’opposizione tra possibilità di preservare la natura e opportunità di piena occupazione e di sviluppo produttivo. È allora doppiamente necessario per Keucheyan alimentare un dibattito sui temi ecologici che superi la separatezza, se non addirittura l’opposizione, tra questione ambientale e giustizia sociale. Bisogna costruire discorsi pragmatici sulla crisi ambientale che non la separino da quella sociale, che inducano all’azione, che sollecitino la dimensione etica senza divenire paralizzanti, senza indurre i soggetti a rinchiudersi nell’impegno individuale o, ancor peggio, a abbandonarsi alla disperazione che si prova quando si ha la sensazione che, ormai, sia “tutto perduto”.
La filosofia del Novecento – si pensi ad esempio alla riflessione di Arendt, Anders, Canetti – di fronte alla rapida evoluzione della tecnica e all’impatto dell’attività antropica sul mondo, all’abnorme e all’imponderabile che si erano manifestati nell’impiego dell’atomica, emblema della dismisura umana, si era interrogata sul nesso tra prevedibilità e responsabilità. Keucheyan, sulla scorta di Giddens, Habermas, Ewald e Beck, ripensa questa implicazione a partire dal tema dell’imprevedibilità del rischio. «Nella postmodernità, alcuni rischi sono diventati così costosi da non essere più assicurabili secondo i criteri dell’assicurazione moderna. Sfuggono al controllo degli esseri umani anche quando sono stati creati da loro» (p. 81) «alla fine del XIX secolo comincia a profilarsi l’idea che gli incidenti e gli altri imprevisti sul luogo di lavoro non siano imputabili a qualcuno, che dipendano da un rischio insito nell’attività industriale (…). Diversamente dalla responsabilità, il rischio non è il prodotto di nessuna intenzionalità, è un principio impersonale» (p. 83). Nella rappresentazione attuale della crisi ambientale la sostituzione della responsabilità collettiva e individuale (personale) con il rischio (impersonale) inibisce la possibilità di costruire quel fronte comune necessario a impedire la messa a profitto la natura, a ripensare globalmente le strategie di sopravvivenza per il pianeta, e per l’uomo.
La ridefinizione del rapporto tra uomo e natura è dunque strettamente collegata a quella del rapporto degli uomini (e delle donne) fra di loro, così come sono implicate l’un l’altra la giustizia ambientale e quella sociale, la sfida e la crisi ecologica e quella politica. Ne Il principio di responsabilità (1979), Jonas suggerisce che, in un futuro non troppo lontano, l’umanità potrebbe pagare la sua salvezza dall’annientamento fisico a caro prezzo, con la moneta della libertà. Il pericolo è che si configuri una situazione per cui solo una tirannia, una dittatura benevola potrà inibire l’uomo a continuare a arrecare danni irreparabili all’ambiente e dunque a se stesso, compromettendo le possibilità di sopravvivenza sue e delle generazioni future (p. 121). Keucheyan, seguendo l’ipotesi di Jonas, si interroga su chi, in mancanza di sbocchi alternativi, di fronte a questa congiuntura critica, possa essere adeguatamente preparato al compito e assumere il potere. Non certo l’élite politico/finanziaria, sempre più incline a un «breve-terminismo che la rende incapace a inserire il cambiamento climatico il cambiamento climatico nei suoi calcoli» (p. 119). Solo i vertici militari e i loro apparati sembrano essere in grado, attualmente, di pianificare la loro azione su un arco temporale medio-lungo, di trenta/cinquanta anni, «nulla fa pensare a priori che questa tirannia sarà militare. Ma il grado di preparazione delle forze armate di fronte alla crisi ecologica suggerisce che potrebbero essere dei seri candidati per assumere il comando. L’adattamento al cambiamento ambientale, in ogni caso, richiederà una dimensione militare decisiva» (p. 121). In quest’ottica – seguendo un ragionamento certo inquietante nel suo catastrofismo, ma non implausibile – la crisi ambientale si configura come crisi dell’umano non solo nel senso della zoé, ma anche del bios. Con il disastro ecologico non si mette in pericolo la “sola” sopravvivenza fisica, ma, prima ancora, la vita politica – intesa come libertà, piena capacità e possibilità di decisione – del genere umano.
A meno che, auspica Keucheyan, proprio i soggetti più colpiti dalla crisi ecologica non facciano fronte comune e, cambiando i rapporti di forza e ripensando le politiche sociali e ambientali, si facciano carico di questo compito e scrivano un finale diverso della storia. Insomma, ecologismo o barbarie.
——————————————
“il manifesto” – 27.3.2019
Un’ecologia politica che mette in discussione il capitalismo
di Massimo Filippi
Scaffale. «La natura è un campo di battaglia» di Razmig Keucheyan per Ombre corte. L’analisi del sociologo francese si snoda lungo tre grandi direttive: il razzismo ambientale, la finaziarizzazione della natura e la militarizzazione dell’ecologia
Ormai è impossibile negarlo: siamo immersi in una crisi ecologica di proporzioni inaudite. Ciò che invece è ancora poco compreso – anche dalla stragrande maggioranza, più bianca che verde, dei movimenti ambientalisti – è che sull’orlo del baratro non ci ha portato quell’universale astratto che risponde al nome di «umanità», ma quell’universale concreto che si chiama capitalismo.
QUESTA È LA TESI che innerva La natura è un campo di battaglia di Razmig Keucheyan appena tradotto per i tipi di Ombre corte (pp. 168, euro 15). La natura, infatti, «non sfugge ai rapporti di forza sociali», anzi «è la più politica tra le entità» non fosse altro perché il capitalismo non potrebbe pensarsi senza l’appropriazione del lavoro della natura e di chi naturalizza (schiavi, donne e animali). A partire da questa prospettiva, l’ecologia politica del sociologo francese si snoda lungo tre grandi direttive: il razzismo ambientale, la finaziarizzazione della natura e la militarizzazione dell’ecologia.
Razzismo ambientale è un modo per esprimere con chiarezza che le conseguenze della crisi ecologica non colpiscono – e, almeno per un bel po’, non colpiranno – uniformemente tutti gli appartenenti alla specie Homo sapiens – per non parlare degli altri viventi animali -, ma certe classi più di altre, come testimoniano, ad esempio, la localizzazione delle discariche di rifiuti tossici nei pressi della aree urbane più povere e marginalizzate o la prevalenza dei neri tra le vittime dell’uragano Katrina. Preso atto che la natura costituisce un ulteriore asse di distribuzione dei rapporti di forza e che le disuguaglianze ambientali non potranno che aumentare nel prossimo futuro, Keucheyan, invece di unirsi agli appelli fuorvianti secondo cui potremmo gestire il cambiamento climatico superando le divisioni di classe, genere e razza, passa ad analizzare i meccanismi che il capitalismo mette in atto per governare la crisi ecologica a proprio vantaggio.
Il primo di questi meccanismi è la finanziarizzazione della natura che è cresciuta esponenzialmente con l’aumentare del degrado ambientale. Come può l’impresa capitalista assicurare i propri beni e le proprie merci nel momento in cui il cambiamento climatico può causare danni enormi, correlati e difficilmente prevedibili nel tempo e nello spazio? Semplice: realizzando un sistema globalizzato di distribuzione dei rischi – con l’invenzione, tra gli altri, dei «derivati climatici» e delle «obbligazioni catastrofe» -, sistema che coinvolge anche gli Stati con la consueta funzione di collettivizzare i costi e di sorvegliare che la privatizzazione dei profitti prosegua indisturbata. La finanziarizzazione della natura è il più fulgido esempio contemporaneo della plasticità auto-rigenerativa del capitalismo di fronte alle sue stesse contraddizioni, in quanto «protegge l’investimento dalle conseguenze del cambiamento climatico e consente nel contempo di trarne profitto».
IL SECONDO MECCANISMO analizzato da Keucheyan è quello della militarizzazione dell’ecologia. «Nei ragionamenti dei militari» il cambiamento climatico non può che essere interpretato come «moltiplicatore di minacce» che, pertanto, necessita dell’intervento sempre più massiccio di «specialisti del caos». Al pari del precedente, anche questo meccanismo opera a livello transnazionale mobilitando, esattamente come nel caso del terrorismo, la retorica della sicurezza collettiva e la violenza materiale dell’apparato militar-industriale dell’Occidente. Con il crescere del disastro ambientale, la cornice capitalista non può che prevedere una sorta di guerra verde permanente per poter difendere i privilegi delle élite di fronte a moltitudini sterminate a cui manca o mancherà, letteralmente, la terra sotto ai piedi.
Ecco spiegato perché, per parafrasare Mark Fisher, ci è più facile immaginare la fine del mondo che quella del capitalismo: «il capitalismo non morirà di morte naturale» in quanto «non solo è capace di adattarsi alla crisi ambientale, ma anche di trarne vantaggio». Certo, forse non per sempre. Ma, piuttosto che affidare le sorti nostre e del mondo a una qualche forma di destinalità religiosa, non sarebbe ora di «politicizzare la crisi», di sottrarre il nostro destino alle mani del capitale?
EFFIMERA
La natura è un campo di battaglia: tra crisi fiscale dello Stato e processi di finanziarizzazione – di Razmig Keucheyan
LE PAROLE E LE COSE
UN ASSAGGIO
Introduzione
Nell’autunno del 1982, gli abitanti della contea di Warren, nel nord-est della Carolina del Nord, si sono mobilitati per sei settimane contro l’installazione di una discarica di rifiuti tossici. Quattro anni prima, nel 1978, un’impresa di gestione dei rifiuti industriali aveva depositato illegalmente nell’area grandi quantità di policlorobifenili (pcb), una sostanza utilizzata in particolare nei trasformatori elettrici e nella vernice. Una volta scoperte, lo Stato della Carolina del Nord decise di acquistare un terreno per sotterrarle. Furono previsti diversi luoghi, ma alla fine si optò per un terreno vicino alla città di Warrenton. I residenti del luogo, come spesso accade in simili circostanze, si opposero alla scelta, temendo per la loro salute, dato che il pcb è una sostanza cancerogena. Intentarono un’azione legale per impedire che i rifiuti fossero conservati in quel luogo. Due anni dopo, il tribunale distrettuale rigettò la loro richiesta. Fu allora che la protesta iniziò ad assumere una forma extragiudiziale: manifestazioni, sit-in, boicottaggi, disobbedienza civile, marce, meeting, blocchi stradali… Queste azioni portarono all’arresto di più di cinquecento persone, compresi alcuni parlamentari locali e federali. Il movimento non riuscì a ottenere l’abbandono del progetto nell’immediato e il luogo fu decontaminato solo nel Duemila.
Inizialmente, gli argomenti addotti dai contestatori contro la discarica si riferivano all’inquinamento dell’ambiente (acqua e suolo) da parte del pcb e ai rischi che presentava per la salute. Tuttavia, man mano che il movimento si estendeva e diventava più politico, gli argomenti cambiarono natura. Se lo Stato aveva scelto di seppellire i rifiuti tossici in quel luogo, affermavano i residenti e i loro sostenitori, era perché vi vivevano dei neri, dei poveri e soprattutto dei neri poveri. In altre parole, la decisione di costruire la discarica aveva un fondamento razzista. All’epoca, la contea di Warren era composta al 64 per cento di neri. L’area immediatamente adiacente alla discarica lo era sino al 75 per cento. I contestatori facevano osservare che questa ingiustizia nella localizzazione dei rifiuti tossici non si registrava solo nella Carolina del Nord ma in tutti gli Stati Uniti, e dalla fondazione del paese. Nelle sue politiche di gestione dell’ambiente e delle risorse, lo Stato favorisce sistematicamente le popolazioni bianche e le classi medie e superiori, che preserva da questo tipo di inquinamenti. Al contrario, le minoranze, non solo i neri, ma anche i nativi, gli ispanici e gli asiatici, così come i poveri, subiscono la maggior parte delle conseguenze negative della produzione industriale. Ancora oggi, si osserva che negli Stati Uniti le multe per il trattamento non conforme dei rifiuti sono cinque volte più frequenti quando i fatti hanno avuto luogo in prossimità di quartieri bianchi, e non neri o ispanici. Questa discriminazione razziale non è necessariamente intenzionale da parte dei poteri pubblici, anche se spesso è così. È sistemica, scaturisce cioè da una logica in parte indipendente dalla volontà degli individui. Ciò che ha permesso al movimento della contea de Warren di crescere è dunque la sua capacità di generalizzarsi, di “agganciare” una rivendicazione locale a un’ingiustizia globale.
Questo episodio illustra perfettamente la tesi principale di questo libro: la natura è un campo di battaglia. Già oggi è – e lo sarà sempre di più nel futuro, man mano che la crisi ecologica si aggraverà – il teatro di conflitti tra diversi attori con interessi opposti: movimenti sociali, Stati, eserciti, mercati finanziari, compagnie assicurative, organizzazioni internazionali… Nel caso della contea di Warren, il conflitto è il prodotto di una forma particolare di ingiustizia, il razzismo. Ma può nascere da altre tipi di disuguaglianze. La natura non sfugge ai rapporti di forza sociali: è la più politica tra le entità.